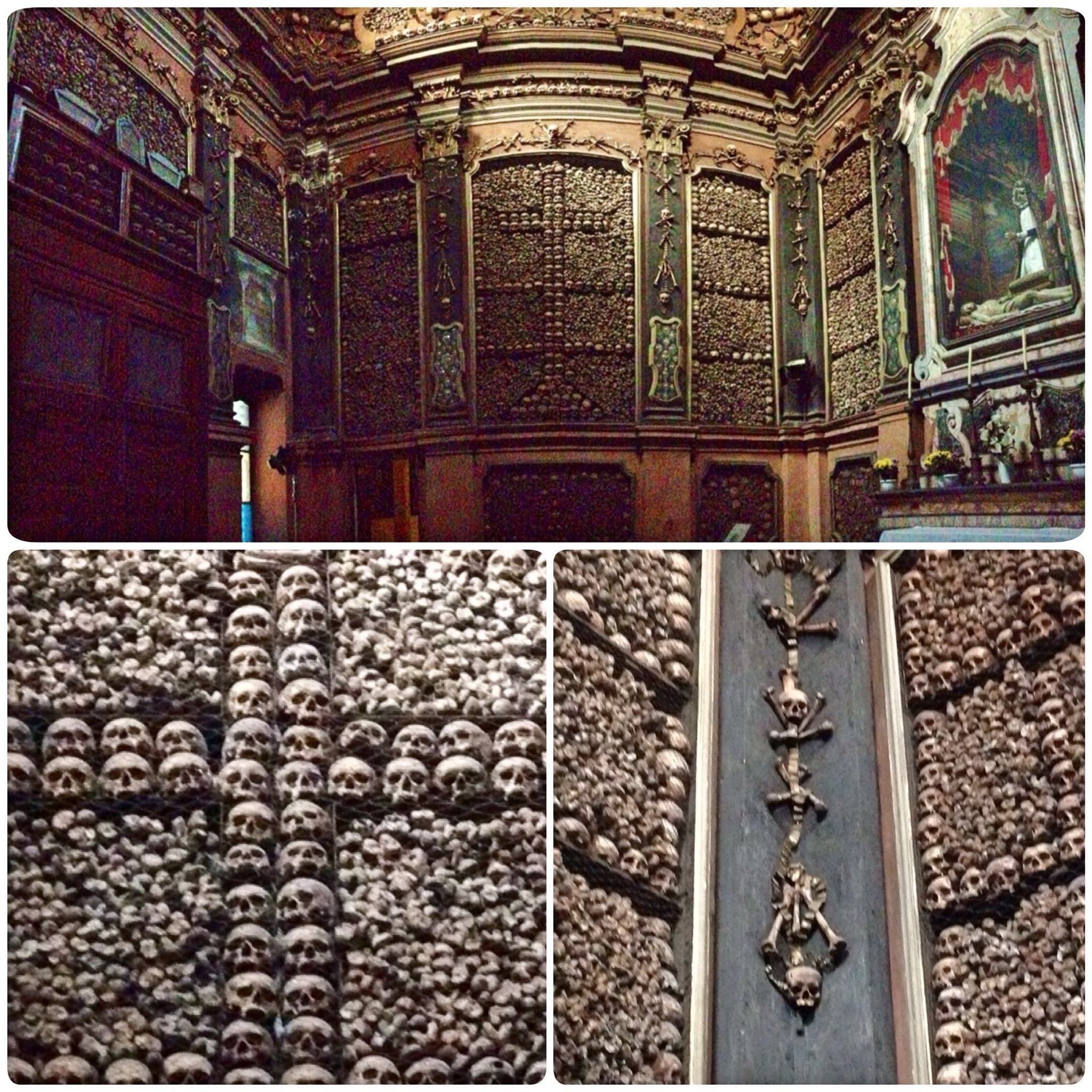Sono stata la prima volta a Venezia da bambina con la mamma, mi sembra fosse il 1998, quando i treni veloci si chiamavano ancora Pendolini. Mi colpirono soprattutto le prigioni (i Piombi, dove fu rinchiuso anche Giacomo Casanova, e i terribili Pozzi) e gli strumenti di tortura conservati nella Camera del Tormento di Palazzo Ducale. Poi mi ricordo moltissimi piccioni in piazza San Marco e la gente che se li faceva salire in testa per scattare foto ricordo di dubbio gusto. Effettivamente all’epoca ce n’erano molti di più rispetto a oggi, perché nel frattempo un’ordinanza comunale ha imposto il divieto di dar loro da mangiare. I venditori di mangime per piccione si sono dileguati e sono in compenso comparsi i venditori di bastoni estensibili da selfie, che adesso pare vadano per la maggiore… Piazza San Marco rimane zeppa di turisti in ogni stagione, ma le cupole dorate della Basilica riescono miracolosamente a farli zittire tutti d’un colpo.
Dieci anni dopo quella prima volta sono tornata a Venezia con Angelo: era novembre e stavamo al Lido, che in quel periodo era deserto. C’era la Biennale di architettura e abbiamo gironzolato tra i padiglioni; siamo andati a vedere gli artigiani a Murano e Burano; siamo diventati esperti delle tratte dei vaporetti. Mi ricordo che ero tornata a casa pensando che Venezia era bella ma un po’ triste e molto finta: troppi negozi di paccottiglia, troppa ressa, troppe trappole per turisti. L’altro giorno in libreria mi sono imbattuta in un pamphlet di Salvatore Settis, archeologo e storico dell’arte, intitolato Se Venezia muore e pubblicato da Einaudi: rielaborando un discorso tenuto all’Ateneo Veneto nel 2012, denuncia l’impoverimento dovuto alla monocultura turistico-alberghiera che starebbe insidiosamente condannando Venezia a una morte lenta ma inevitabile – se non ne prenderemo coscienza.
Le città storiche sono insidiate dalla resa a una falsa modernità, dallo spopolamento, dall'oblio di sé. Di questa minaccia, e dei rimedi possibili, Venezia è supremo esempio. Dobbiamo ritrovarne l'anima, rivendicare il diritto alla città.

Venezia è un luogo unico al mondo, viene ricostruita pari pari in paesi lontani, innamorati di ogni dove l’hanno eletta città romantica per eccellenza (perfino i miei genitori, che ci sono andati in luna di miele negli anni Settanta). La sua storia è la storia d’Italia: i pittori, gli esploratori, gli scrittori… Dal 1987 fa parte dei siti inscritti nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. E tuttavia o forse proprio per questo i turisti arrivano in massa, i veneziani fuggono sulla terraferma, il made in china svaluta il lavoro degli artigiani e tradizioni secolari. La situazione è delicata: eppure, quest’anima antica di fierezza ed eleganza, mi sono accorta nell’ultimo viaggio che Venezia la mantiene e la conserva. Per ogni residente che si trasferisce a Mestre o Marghera c’è magari un ragazzo o una ragazza giovane che decide di venire a studiare a Ca’ Foscari e, una volta finita l’università, decide di fermarsi a vivere in questa città di cui si è follemente innamorato. Questa è anche la storia di Marialisa, che da Venezia non è più tornata. Ora lavora alle Gallerie dell’Accademia, che espongono tra le altre cose la Tempesta di Giorgione e conservano – nascosto però al pubblico – il celeberrimo Uomo Vitruviano di Leonardo. La mia amica odia Piazza San Marco (come tutti i veneziani, dice) perché ogni mattina è una lotta e gimcana tra gli assembramenti di turisti che si agitano cercando l’inquadratura perfetta. Poi però arriva al Ponte dell’Accademia, col sole rosa che sorge dietro alla Salute, e rallenta il passo per godersi quel momento magico.
Boicottiamo quindi (con affetto) Piazza San Marco, per seguire un itinerario un po’ sghembo e tuttavia molto riuscito 🙂
Una libreria particolare
Nel sestiere Castello, in Calle Longa Santa Maria Formosa, c’è una libreria che si chiama Acqua Alta. L’ha aperta una decina di anni fa un signore di nome Luigi Frizzo, che insieme ai suoi gatti sornioni accoglie i visitatori con l’aria di chi è molto orgoglioso della sua tana. La libreria, che nel 2014 è stata inclusa dalla Bbc nella lista delle 10 librerie più belle del mondo, deve la sua unicità a quella della città in cui si trova: quando a Venezia c’è l’acqua alta, infatti, la libreria si allaga e il signor Luigi, con indosso gli stivaloni, si prodiga per spostare i libri dei ripiani più bassi al riparo dall’acqua. Impresa ardua, perché qui i libri sono in ogni angolo, ammucchiati (senza troppa logica) su scaffali, tavoli, mensole, addirittura dentro vasche da bagno, barili, canoe, e una gondola che si allunga maestosa nella prima sala della libreria. I libri si trasformano in mattoni per costruire muri e gradini che formano una scala nel terrazzino con vista sul canale. Mi è piaciuta perché da sempre sostengo l’estetica del mucchio, ma sinceramente mi si è stretto un po’ il cuore, a vedere tutti questi libri in balìa delle intemperie, calpestati, ammuffiti; a sentire quell’odore forte di umido e piscio di gatto che, diciamolo, un po’ stempera la poesia di questo luogo.
Andar per cicchetti e una sorpresa gastronomica
Che fa uno a Venezia quando gli vien fame? Va in un bacaro, ordina un’ombra e la accompagna con un paio di cicheti. Il mio fidato dizionario etimologico (aka Wikipedia) propone le seguenti spiegazioni per queste bellissime parole del dialetto veneziano: bàcaro, l’osteria/enoteca, deriva da Bacco, dio del vino, o dal detto “far bacara” ovvero “festeggiare”; bacari erano anche i vignaioli che vendevano il loro vino in Piazza San Marco, in bicchieri che venivano chiamati ombre perché, per proteggerli dal sole, i venditori spostavano i barili lungo il tragitto segnato dall’ombra del campanile. Cicchetto invece viene da “ciccus”, piccola quantità in latino, e rivela l’antica storia di questi stuzzichini che accompagnano le bevute. I cicheti vengono venduti al pezzo, come le tapas spagnole, e volendo ci si può fare un pranzo intero. Più spesso, però, se ne scelgono un paio, giusto per non bere a stomaco vuoto – anche se al quarto spritz le certezze vacillano… Infatti noi dopo i primi due ciccheti al baccalà mantecato al Bottegon (già Schiavi) di San Trovaso – che ci hanno, come si suol dire, aperto la voragine – ci siam fatti un panino con la soppressa e uno con la porchetta. Dio benedica la soppressa, che ha segnato il nostro weekend veneziano: menzione d’onore a quella cotta nell’aceto con radicchio marinato, polenta e noci che abbiamo mangiato sabato sera Al Portego (ottima osteria con ottima selezione musicale!). La domenica, invece, Marialisa ci ha portato a mangiare in Campo Santa Margherita, in un piccolo ristorante take away che si chiama Orient Experience – altrimenti conosciuto come “l’afghano”. Venezia porta d’Oriente e tradizione di accoglienza, popoli e culture che si sedimentano l’uno sull’altro, la carne saporita dell’agnello, i ceci croccanti, lo yogurt che avvolge la bocca.
Gli orecchini di Mrs Peggy G.
Se vi piacciono l’arte moderna e contemporanea, la collezione Peggy Guggenheim vi farà impazzire. Peggy la miliardaria è stata una delle figure più importanti della storia dell’arte del Novecento, per il suo ruolo di collezionista, mentore e amica dei più grandi artisti del secolo breve. Nacque nel 1898 a New York da Florette Seligman, figlia di banchieri, e Benjamin Guggenheim, che morirà nel 1912 nel naufragio del Titanic: è quello che nel film, nel momento di panico totale, scende dal grandioso scalone del transatlantico con tuba e smoking accanto al suo valletto e pronuncia la leggendaria frase “Abbiamo indossato il nostro abito migliore e siamo pronti ad affondare da gentiluomini. Ma gradiremmo un brandy!”. Poco più che ventenne, Peggy arrivò a Parigi, dove frequentando i circoli bohémien delle avanguardie europee conobbe artisti come Costantin Brancusi, Marcel Duchamp e Man Ray. Ebbe una vita sentimentale turbolenta, segnata da alcuni grandi amori (Laurence Vail, squattrinato artista dada, primo marito e padre dei due suoi figli; John Holms, eroe di guerra col blocco dello scrittore; Max Ernst, secondo marito e pioniere del Surrealismo) e molti flirt – pure con Samuel Beckett. Nel 1937 aprì la sua prima galleria d’arte, a Londra (fu lei a esporre per la prima volta Kandinsky in Inghilterra); poi cominciò a collezionare opere di artisti più o meno emergenti come Picabia, Braques, Mondrian, Léger, Dalì, Picasso, finché non fu costretta ad abbandonare la Francia occupata. Tornata negli Stati Uniti inaugurò nel 1942 a New York la galleria/museo Art of this century, indossando per la serata inaugurale un orecchino di Yves Tanguy e uno di Alexander Calder, a dimostrazione della sua “imparzialità tra l’arte astratta e quella surrealista”. Prese sotto la sua ala protettrice il giovane Jackson Pollock, di cui nel novembre 1943 espose la prima personale; attorno a Peggy e alla sua galleria si sviluppò il grande movimento dell’espressionismo astratto americano con Rothko, Klein, De Kooning. Nel 1947 tornò in Europa e nel 1948 acquistò Palazzo Venier dei Leoni, un antico edificio sul Canal grande dove negli anni Venti aveva abitato un’altra donna dalla storia straordinaria, l’eccentrica marchesa Teresa Casati. Peggy Guggenheim si trasferì qui insieme alla sua collezione, che aprirà al pubblico nel 1951 e verrà in varie occasioni esposta all’estero. Passerà a Venezia il resto della sua vita, continuando a supportare i suoi artisti e a collezionare opere che sono oggi entrate nel canone dei classici moderni – oltre agli artisti già citati, De Chirico, Mirò, Klee, Magritte, Giacometti, Manzoni. Cubismo, astrattismo, surrealismo, futurismo, pittura metafisica: la collezione, che adesso è gestita dalla Fondazione Solomon R. Guggenheim (lo zio ricco…), rappresenta una delle più complete raccolte in Italia del modernismo europeo ed americano della prima metà del XX secolo. Alla collezione permanente di Peggy si aggiungono la collezione Hannelore B. e Rudolph B. Schulhof, la collezione Gianni Mattioli (che include alcuni capolavori del futurismo italiano, tra cui Boccioni, Carrà, Depero) e il Patsy R. and Raymond D. Nasher Sculpture Garden. Se cercate bene, tra le sculture del giardino trovate una lapide: qui riposano infatti le ceneri di Peggy, che volle essere seppellita accanto ai suoi “beloved babies”: non i suoi artisti stavolta, ma i suoi quattordici cagnolini!
Dinosauri e cerbiatti a due teste
Il museo di Storia naturale di Venezia ha sede dal 1923 nel palazzo detto Fontego dei Turchi, che dal 1621 al 1838 fu utilizzato dai mercanti turchi come sede dei loro commerci. Restaurato da poco, oggi conserva tra le varie collezioni naturalistiche e scientifiche più di due milioni di pezzi. E’ molto bello e vale davvero la pena di una visita, non fosse altro che per l’incredibile scheletro di dinosauro che svetta nella prima sala: si tratta del calco di un Ouranosaurus nigeriensis, scoperto nel 1965 nel deserto del Niger durante una spedizione capitanata dagli archeologi Giancarlo Ligabue e Philippe Taquet. Occhio poi a non inciampare nelle fauci del terribile Sarcosuchus imperator, un giga coccodrillo vissuto circa 112 milioni di anni fa. Il percorso museale prosegue con una collezione pazzesca di minerali, rocce e fossili, per poi arrivare a una serie di sale dedicate ad alcuni uomini molto diversi tra loro, ma accomunati da viaggi lontani e spirito d’avventura. Uno di loro è l’esploratore Giovanni Miani, che donò a Venezia nel 1862 i materiali etnologici da lui raccolti nel corso delle sue spedizioni alla ricerca delle sorgenti del Nilo (per la cronaca, non ci arrivò mai), accompagnati da manoscritti, disegni e il suo diario autografo. Un altro è il già citato Ligabue, a cui si devono una miriade di reperti divisi tra le sezioni di paleontologia, paleoantropologia ed etnologia. Ma la collezione più incredibile di tutte è quella del conte Giuseppe De Reali, che raccoglie su pareti lugubremente rosse i trofei accumulati durante le sue spedizioni di caccia grossa in Africa Orientale e in Congo tra 1898 e 1929. E’ raccapricciante, perché molte delle teste appese in queste sale appartenevano ad animali oggi estinti, e le foto d’epoca che lo ritraggono accanto agli esemplari appena uccisi – con moglie grassoccia vestita di bianco al suo fianco – mi hanno fatto davvero rabbrividire.
Del resto, impulso primario del collezionista è proprio quello di poter possedere, ed eventualmente esporre agli occhi increduli degli ospiti e dei visitatori, una pletora di cose straordinarie nel senso letterale del termine, e cioè nuove, diverse, preferibilmente dal sapore esotico, lontano, mitico. Una vera e propria Wunderkammer, nella tradizione di quelle camere delle meraviglie che affondano le proprie radici nel Medioevo, raggiungono la massima popolarità nel Cinquecento e nei barocchismi seicenteschi, e nel Settecento illuminato da Linneo e le sue classificazioni scientifiche costituiscono il nocciolo da cui si svilupperà il concetto di museo modernamente inteso. Non a caso il padiglione più propriamente museologico del Museo di Storia naturale è introdotto dalla ricostruzione di una Wunderkammer, in cui fanno bella mostra di sé naturalia e artificialia da rimanere a bocca aperta, come una tsantsa (testa umana privata del cranio e rimpicciolita alle dimensioni di un pugno, preparate con grande abilità dagli indios cacciatori di teste dell’alta Amazzonia, allo scopo di vendicare una persona e placarne lo spirito tormentato), un cerbiatto e un vitellino a due teste, e addirittura due basilischi, creature fantastiche costruite componendo pezzi di vari animali.
Ed ecco che, usciti da questa bizzarra stanza, si apre ariosa la storia naturale analiticamente illustrata e spiegata, i misteri dell’evoluzione vengono svelati e le infinite strade della vita sulla terra raccontate con chiarezza e precisione. Stupiscono le collezioni zoologiche, in particolare quelle entomologiche, ornitologiche e malacologiche (i molluschi); in ambito botanico sono affascinanti gli antichi erbari, l’algarium, la raccolta micologica (il Museo di Storia naturale di Venezia ospita la più grande e meglio conservata raccolta di funghi in Italia!). Degne di nota anche la collezione di antichi strumenti scientifici e la collezione anatomica, la cui star è lo scheletro alto più di due metri dell’ultimo campanaro di San Marco, vissuto a metà Ottocento. Pare che stia al suo posto fino a qualche minuto prima di mezzanotte, ora in cui sale sul campanile per dare i rintocchi alla campana più grande…
La casa di Aldo Manuzio in Rio Terà Secondo: una chicca per bibliofili

Aldo Manuzio era un vero figo: considerato il primo editore in senso moderno, ha apportato alla storia del libro e dei sistemi editoriali una serie di innovazioni che hanno attraversato i secoli fino ad oggi. Snocciolandone alcune: si deve a lui l’idea di stampare i libri in ottavo, cioè in un formato più piccolo e maneggevole (sono gli antenati dei nostri tascabili). Ha utilizzato per la prima volta il corsivo, che in inglese si chiama italics proprio per la sua origine italiana; ha dato definitiva sistemazione alle norme di punteggiatura; ha inventato il punto e virgola! Pubblicò circa 130 edizioni in latino, greco e volgare, una sorta di biblioteca perfetta dell’Umanesimo. Uno dei suoi capolavori è l’Hypnerotomachia Poliphili (La battaglia amorosa di Polifilo in sogno) di Francesco Colonna, pubblicato nel 1499 e ritenuto il libro stampato più bello del Rinascimento italiano, grazie alle finissime xilografie che lo illustrano.
Un (breve) giro in gondola
Poiché una volta si entrava nelle case direttamente dai canali, Venezia assume un aspetto completamente diverso vista dall’acqua; di alcuni edifici, infatti, noi non vediamo che il retro, dato che la facciata è quella rivolta sui canali. La gondola, simbolo incontrastato della città, è stata per secoli il mezzo più adatto per spostarsi lungo le vie d’acqua della città. Poi sono arrivati i vaporetti e i taxi e le gondole sono diventate un’attrazione turistica, anche piuttosto cara… Non tutte però! A Venezia può capitare di finire di fronte al posto in cui si vuole arrivare, ma non poterlo raggiungere perché c’è un canale di mezzo: quindi o si cammina fino al ponte più vicino, o si attraversa il canale in gondola. L’attraversamento costa 0.70 centesimi per i residenti e 2 euro per i turisti. Chi vuole spacciarsi per veneziano dovrebbe: arrivare con le monete contate; dissimulare l’emozione di trovarsi su una gondola; non fare quelli che “oddio cado oddio cado!”; evitare di scattare fotografie col gondoliere. 2 euro per un minuto scarso di navigazione è tanto, ma alla fine li abbiamo pagati, dato che abbiamo infranto tutte le regole… diciamo che l’abbiamo considerata una tassa sul selfie 😛
Insomma questa volta Venezia mi è sembrata più vera e più viva, forse perché ho fatto più attenzione ai dettagli, perché ho ascoltato le voci squillanti dei suoi abitanti mentre ci affrettavamo lungo le calli. Grazie Marialisa, per averci spiegato le sfumature del polivalente “ghe sboro!” e per averci mostrato la tua Venezia 🙂